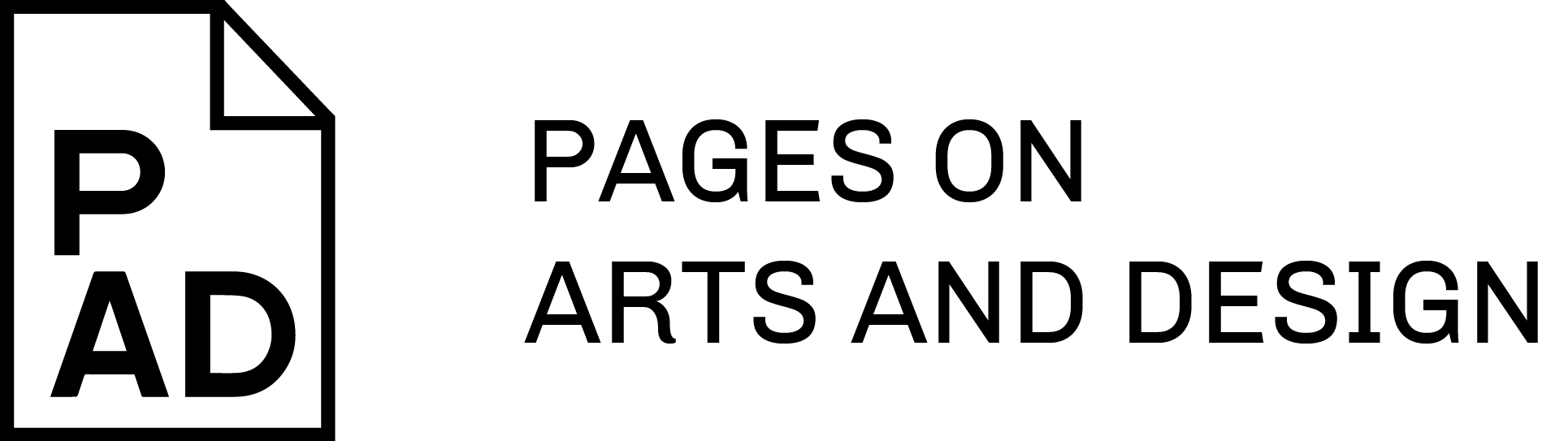1. Richard Avedon e la Sicilia delle illusioni
Come lunga ombra alzatasi per prodigio o maleficio dalla terra contro il cielo nell’ultima luce del crepuscolo e alta sulla folla in processione in una via di Palermo, una figura d’uomo cammina su trampoli coperti da calzoni a quadretti di clown gigante e fuori misura. L’immagine di questa scena porta la data del 2 settembre 1947, il giorno immediatamente precedente la notte del secolare pellegrinaggio popolare verso la grotta di Santa Rosalia e viene scattata da un giovane ventiquattrenne di New York, Richard Avedon, che già da qualche anno lavorava per la rivista “Harpers’ Bazar” chiamato dall’art director Alexei Brodovitch, di cui era stato studente alla New School for Social Research. Durante la permanenza isolana di quell’anno e in quelle successive, altre fotografie importanti vengono scattate da Avedon, ma questa per lui è talmente significativa da essere scelta come inizio della sua opera definitiva, la monumentale Autobiografia del 1993. “Questo libro segue la traccia di tre cruciali illusioni della mia vita”, scrive Avedon in prefazione: “La prima sezione riguarda l’illusione della risata e la scoperta della linea sottile tra ilarità e panico da parte di un giovane. La seconda sezione riguarda l’illusione del potere. La terza sezione riguarda la perdita di tutte le illusioni”.
Il giorno di questo scatto rappresenta quindi per Avedon la data di nascita in quanto artista e l’immagine dell’uomo sui trampoli diventa la cifra enigmatica e il segno esplicativo dell’intera sua opera come ritrattista e come fotografo dei grandi della moda nella seconda metà del novecento: l’ergersi del genere umano rispetto alla china bassezza dell’animale, il suo nascondere con la maschera dell’abito la nudità del corpo e la povertà dell’anima, il suo alzare il simulacro della memoria e l’azione della storia sull’orizzonte immemore e immutabile del mondo, il mistero del sorriso nel volto che improvviso irrompe dalla profondità oscura delle viscere sull’aprirsi irrefrenabile delle labbra, nel luminoso oblio dalla pena del vivere e nella felice dimenticanza del dolore e della morte.
Nell’isola del mezzogiorno occidentale che è la Sicilia, tra la solenne liturgia dentro le chiese barocche, la drammaturgia teatrale delle feste religiose e la fastosa tristezza dei funerali, l’intera esistenza dell’uomo, la luce del suo volto, si rivela a Avedon quale scena effimera proiettata dalla forza immaginativa dell’illusione. E, il 17 agosto 1959, nella Cripta dei Cappuccini di Palermo, di fronte alla silenziosa sequenza dei cadaveri distesi dalla pietà cristiana su un giaciglio a simulare il sonno o appesi alle pareti nel macabro scherzo di una vita apparente, molti stringendo ancora nella mano rinsecchita una lettera con la cronaca della vita, Avedon sembra comprendere, attraverso gli scatti che esegue, anche la natura della fotografia: scrittura dello sguardo che spera nella risurrezione dei corpi sul nero sfondo del nulla.
In un breve saggio dedicato a Mario Dondero, commentando l’immagine scattata da Jean-Louis Daguerre nel 1838 dall’alto di una finestra sul Boulevard du Temple, Giorgio Agamben scrive: “La fotografia è per me in qualche modo il luogo del Giudizio Universale, essa rappresenta il mondo come appare nell’ultimo giorno, nel Giorno della Collera […]. L’immagine fotografica è sempre più che un’immagine; è il luogo di uno scarto, di uno squarcio sublime tra il sensibile e l’intellegibile, tra la copia e la realtà, tra il ricordo e la speranza. A proposito della resurrezione della carne, i teologi cristiani si chiedevano, senza riuscire a trovare una risposta soddisfacente, se il corpo sarebbe risorto nella condizione in cui si trovava al momento della morte (magari vecchio, calvo e senza una gamba) o nell’integrità della giovinezza. Origene tagliò corto a queste discussioni senza fine affermando che a risorgere non sarà il corpo, ma la sua figura, il suo eidos. La fotografia è, in questo senso, una profezia del corpo glorioso […] Di tutto questo la fotografia esige che ci si ricordi, di tutti questi nomi perduti le foto[…] testimoniano, simili al libro della vita che il nuovo angelo apocalittico – l’angelo della fotografia – tiene fra le mani alla fine dei giorni, cioè ogni giorno.”
Nel libro della propria vita, Richard Avedon, in ognuno dei tre capitoli, inserisce cinque fotografie siciliane con la metrica precisione di un poema e le utilizza per configurarne il senso profondo, come il ritornante e unificante tema melodico nei diversi movimenti di una sinfonia, fino all’epilogo, dove un volto mummificato da secoli immobile nella Cripta dei Cappuccini con le orbite vuote e la bocca aperta precede il ritratto del poeta anti-semita Ezra Pound che declama un verso, impaginato accanto al ritratto del padre morente Jacob Israel Avedon: l’ultima immagine dell’Autobiografia è il bianco profilo di un viso, bianco e luminoso come uno spirito, a Berlino nella notte dell’ultimo giorno del 1989 che aveva visto la caduta del Muro che divideva il mondo in due, nell’apparente avverarsi del sogno della libertà.
2. La passione come realtà.
In secolare continuità con la tradizione medievale salvaguardata ed esaltata dalla cultura barocca, la Sicilia è l’ultima regione d’Italia e dell’intero Occidente in cui i paesi e le città fermano ogni attività per onorare i riti religiosi delle sante e dei santi patroni e in cui si celebrano ancora, in occasione della Pasqua, i cicli dei misteri e le sacre rappresentazioni della passione, morte e resurrezione del corpo di Gesù Cristo, messi in scena sulle vie e le piazze dell’isola, divenuta per un giorno un’unica e immensa Gerusalemme.
“Si può assistere alla Pasqua siciliana in due modi” scrive Gesualdo Bufalino: “da un balcone o in mezzo alla folla […] Stare giù, nella ressa che gli spari e le musiche e gli alleluia sommuovono e gonfiano come un ingorgo di lava, vorrà dire rompere il muro tra intelligenza e fisicità per ritrovarsi nel cuore di un’esperienza assoluta, dove ora prevalga la commozione ora lo spavento, ora […] la gioiosa certezza di creare noi stessi lo spettacolo che stiamo guardando. Che è uno spettacolo di varia invenzione, metà fiaba comica nel senso dantesco di opera che prenda inizio dalla stretta di una cosa e abbia prospero fine, metà psicodramma […]”. Come nel contemplare le statue a grandezza naturale del Cristo flagellato o del Cristo crocefisso o del Cristo morto nel sepolcro, che ancora affollano le navate e le cappelle delle antiche chiese di tradizione latina, l’indice di realismo di cui si fa esperienza nelle feste religiose siciliane è però straordinario.
Approfondendo l’origine e la genesi del Teatro della Misericordia, ovvero delle rappresentazioni della Passione, Carla Bino afferma: “Il senso di realtà […] è fortissimo ed è la chiave di tutto. Si ha l’impressione di assistere a qualcosa che accade davvero […] Quello che è chiaro è che non si è semplicemente assistito a uno spettacolo – seppur popolare – e che non lo si può né vedere né giudicare con le categorie critiche che appartengono al teatro in senso moderno […]. È altrettanto chiaro, però, che non si è partecipato a una celebrazione liturgica […]. A che cosa si è assistito dunque? Cos’è quella sensazione di presenza e di realtà che si è provata?”. I misteri della settimana santa mettono in scena una “realistica descrizione delle violenze perpetrate su Cristo e il pianto inconsolabile di sua Madre. Questi due aspetti si uniscono in una drammaturgia che ricostruisce il percorso della passione attraverso gli occhi di Maria e da questa prospettiva restituisce l’immagine della carne piagata del Figlio … Il significato del termine rappresentare in relazione tanto alla liturgia quanto al dramma cristiani rimanda al concetto di imago nel Medioevo e alla sua capacità di rendere presente l’invisibile nel visibile, Dio nell’uomo … ripetendo così a suo modo il mistero dell’incarnazione […]”. L’immagine del corpo trafitto del Figlio dell’Uomo messo in scena nelle sacre rappresentazioni, oppure dipinta in quadro o scolpita in una statua diventa in tal modo l’origine del realismo che contraddistingue l’intera arte occidentale sino all’invenzione della fotografia da parte di Jean-Louis Daguerre, la cui ultima opera è una grande tela trompe-l’oeil rappresentante la navata di una chiesa gotica che ha in sezione aurea il luminoso candore di un crocefisso. Nel venir meno della fede nei riguardi della resurrezione dei corpi, anche la realtà della forma e della figura nell’immagine sembra scomparire con essa e Gesualdo Bufalino può affermare con qualche ragione: “La fotografia è un peccato, probabilmente; è l’ottava empietà capitale … v’è un fondo di perversità nell’insistenza con cui ci sforziamo di catturare la luce e d’intrappolarla dentro un rettangolo di cartone. E il reprobo Faust, che era disposto a vendere l’anima pur di fermare l’istante, chiederebbe oggi a Mefistofele non la gioventù ma una Kodak”.
3. La fotografia come questione della lingua.
Luigi Capuana, Giovanni Verga e Federico De Roberto, gli scrittori del Verismo in letteratura, lasciano la Sicilia, in cui sono nati rispettivamente nel 1839, nel 1840 e nel 1861, e si trasferiscono prima a Firenze e poi a Milano per riuscire a elaborare una lingua letteraria adeguata al destino dell’uomo nel tempo che era stato dato loro di vivere. Soltanto nella lingua parlata e scritta tra Firenze e Milano, come Alessandro Manzoni, questi autori trovano la maniera narrativa adeguata per rappresentare i personaggi dell’isola in cui sono nati e farli diventare patrimonio comune della cultura italiana e occidentale. La forma originaria e la forza icastica del dialetto siciliano, insieme alla soggettività psicologica degli autori, devono morire a se stessi e riformularsi in una forma letteraria comune e in una struttura drammaturgica oggettiva e universale, uniche dimensioni della lingua capaci di consentire la rappresentazione e la comunicazione della dimensione chiamata realtà. All’interno della poetica del Verismo, questi scrittori si dedicano in maniera continuativa anche alla fotografia, ma le loro immagini non riescono a raggiungere alcuna valenza artistica significativa. E in esse la Sicilia, con le sue figure di uomini donne e bambini, vi rimane impressa come la banale icona di un’affezione privata, a differenza della loro scrittura che riesce a rispecchiare quella indicibile valenza personale propria della verità dell’uomo e della sua opera. Nell’eredità del Verismo, è con Luigi Pirandello, Elio Vittorini, Salvatore Quasimodo, Giuseppe Tomasi di Lampedusa, Leonardo Sciascia, Stefano D’Arrigo e Giuseppe Bufalino che possiamo continuare a parlare di un contributo specifico della letteratura siciliana alla cultura italiana e occidentale.
Giovane erede di una delle più antiche e nobili famiglie della storia di Milano e della Lombardia, Luchino Visconti, nel 1941, “girando un giorno per le vie di Catania e percorrendo la piana di Caltagirone in una mattina sciroccosa, si innamora di Giovanni Verga”. Nel breve scritto Tradizione e Invenzione, il regista confessa: “A me, lettore lombardo, abituato per tradizionale consuetudine al limpido rigore della fantasia manzoniana, il mondo primitivo e gigantesco dei pescatori di Aci Trezza e dei pastori di Marineo era sempre apparso sollevato in un tono immaginoso e violento di epopea; ai miei occhi lombardi, pur contenti del cielo della mia terra che è così bello quand’è bello, la Sicilia di Verga era apparsa davvero l’isola di Ulisse, un’isola di avventure e di fervide passioni, situata immobile e fiera contro i marosi del Mare Ionio. Pensai così a un film sui I Malavoglia […] nell’entusiasmo di poter dare una realtà visiva e plastica a quelle figure eroiche che hanno del simbolo tutta la forza allusiva e segreta senza averne l’astratta e rigida freddezza […]. Se un giorno avrò la fortuna e la forza di realizzare il film sognato su I Malavoglia […] servirà a spalancare uno scenario favoloso e magico dove le parole e i gesti dovranno avere il religioso rilievo delle cose essenziali alla nostra umana carità.” Nel 1947 Luchino Visconti riesce a tramutare il suo sogno in realtà ed insieme ai pescatori di Aci Trezza, che in dialetto siciliano creano al momento i dialoghi del film, realizza La terra trema. In una sorta di ribaltamento del procedimento narrativo proprio dei veristi e di Verga, il neo-realista Visconti può utilizzare il dialetto siciliano grazie alla forma comune e alla struttura oggettiva e universale dell’immagine creata dall’obiettivo. In geniale contemporaneità con la poetica del Neo-realismo e del film La terra trema, i fotografi siciliani trovano la modalità narrativa capace di inserirli nel contesto della cultura italiana e occidentale, dapprima con Nicola Scafidi, poi con Enzo Sellerio e quindi con Ferdinando Scianna e Letizia Battaglia, sino a Carmelo Bongiorno, Carmelo Nicosia e Sandro Scalia.
4. Tra luce e lutto.
Dopo intensi bombardamenti aerei e navali, la notte tra il 9 e il 10 luglio 1943, da una flotta di oltre mille navi, sbarcano tra Gela e Licata le truppe americane comandate dal Generale George Patton e tra Noto e Pachino le truppe inglesi comandate dal Generale Bernard Montgomery. Questa data segna la ripresa della guerra in Europa occidentale per la liberazione dalla dittatura nazi-fascista e l’anticipata fine del conflitto bellico per gli abitanti della Sicilia. Per l’isola inizia però una lunga stagione di conflitti civili e di radicale trasformazione della società con le tensioni innescate dal separatismo e dal banditismo, che hanno in Salvatore Giuliano la figura di riferimento, e con le divisioni delle forze politiche riformiste che si polarizzano tra la via democratica della nascente Democrazia Cristiana attorno al carisma di Luigi Sturzo e la via della rivoluzione auspicata dal proletariato contadino, organizzata dal Partito Comunista Italiano uscito da una ventennale clandestinità.
Con l’antologia Americana, edito nel 1941, Elio Vittorini aveva cominciato a diffondere i canoni letterari e visivi della cultura d’oltre oceano, pubblicando i brani degli scrittori più significativi e le immagini dei fotografi più importanti, soprattutto quelle di Walker Evans e Dorothea Lange, dove primaria importanza assumono i paesaggi e i personaggi della sterminata provincia statunitense. Nel fondamentale saggio Viaggio nell’Italia del Neorealismo. La fotografia tra letteratura e cinema, Ennery Taramelli sostiene che in quel momento entrò “in gioco, in questa tensione morale ed estetica della riscoperta della provincia, anche l’acuto disagio sui destini della modernità. Vissuta dai giovani ribelli in un’accezione fortemente romantica di rivolta anti-borghese, la scoperta della provincia decide, nella contrapposizione tra universo urbano e mondo contadino, l’antitesi tra età moderna e epoche premoderne … Allo scenario senza qualità dell’universo metropolitano visto come il luogo di un ordine estraniante e di una razionalità astratta, si inizia a contrapporre un paesaggio fisico e umano volutamente perduto alle ragioni della storia e della cultura ufficiale. Ritrovato nel flusso di una memoria mitica, ancestrale e collettiva, più che individuale e geografica, l’approdo ideale di tanti autori nella provincia dell’infanzia – le Langhe di Cesare Pavese, la Sicilia di Elio Vittorini, la Calabria di Corrado Alvaro – si lega al gesto di una mitica erranza oltre i confini del Tempo e della Storia. Agitato dagli astratti furori di scritture che hanno come modello la narrativa americana come Paesi tuoi di Pavese, ma anche l’estenuante lavorio della memoria proustiana in Conversazioni in Sicilia di Elio Vittorini, volutamente il paesaggio della provincia diviene il luogo di un universo simbolico da rintracciarsi su un ideale atlante storico o geografico.”
Questa è la dimensione in cui si muovono i fotografi siciliani in quegli anni, dimensione che può essere meglio delineata rileggendo la chiusa del romanzo di Elio Vittorini: “Ad evitare equivoci avverto che come il protagonista di Conversazioni in Sicilia non è autobiografico, così la Sicilia che lo inquadra e lo accompagna è solo per avventura Sicilia: solo perché il nome Sicilia mi suona meglio del nome Persia o Venezuela.”
Nicola Scafidi, cresciuto e formatosi nello studio fotografico palermitano del padre, a partire dal 1943 fotografa con i canoni etici del realismo sovietico la dura esistenza, gli scioperi e le lotte civili dei contadini siciliani con i primi delitti di mafia che cominciano a insanguinare le contrade dell’isola. Pubblicate sui più importanti quotidiani e riviste italiane e straniere, da ”L’Unità” al “New York Times”, le fotografie di Nicola Scafidi hanno avuto i più importanti riconoscimenti nella Russia dell’Unione Sovietica e si pongono oggi come la testimonianza più significativa dei primi anni della Repubblica Italiana e della Sicilia che aveva appena conquistato lo statuto di Regione Autonoma.
Più giovane di un anno rispetto a Nicola Scafidi, Enzo Sellerio, come scrive Ennery Taramelli, “aveva vissuto per ventotto anni con gli ideali e i pregiudizi della sua classe sociale: l’orgoglioso riserbo dei borghesi della Palermo intellettuale, nel loro sacrificio oscuro sancito dal conflitto e dalla prigionia di due fratelli durante il fascismo; ma anche il culto delle apparenze e delle forme, la volontà di credere in una idealità manichea come il comunismo stalinista degli anni Cinquanta.” Lo sguardo di Sellerio, però, si concentra subito sul dramma personale e singolare della condizione umana, svolta e rivelata nei gesti e nelle relazioni quotidiane del vivere. Oltre l’apparente caos della storia umana, Sellerio non vede certo il determinismo dell’ideologia, ma l’evento unico e irripetibile della persona che si muove nel mondo incontrando lo sguardo accorato e partecipe del fotografo. Scorrendo le date delle fotografie, confessa Sellerio, ci “si accorgerebbe che la maggior parte delle fotografie risale ad un periodo compreso tra il 1954 e il 1968 […]. Da quell’anno in poi fotografai sempre di meno. Perché? Certamente ci furono alcune ragioni di carattere generale […]. Ma le cause profonde erano ben diverse. Nel 1968 iniziava ufficialmente quella grande stagione della violenza, che ancora oggi imperversa e chissà quando finirà. Il mondo cambia, perché così è scritto: ma di questa metamorfosi travolgente e oscura io, uomo tranquillo, non mi sento di essere il cronista. Non a caso, nel clima attuale, la fotografia più nota e di gran lunga la più pubblicata … è l’unica che parli di violenza: la fucilazione di bambini. Avrei mai fotografato una fucilazione vera? Non credo proprio. Registrai quella scena perché era soltanto un gioco e il gioco è quella forma in cui, più che in ogni altra, la vita dovrebbe essere vissuta: per questo avevo scelto la fotografia.”
La Sicilia di Enzo Sellerio è davvero il luogo dove l’uomo, immerso nel gioco dell’esistenza, può conoscere e amare l’armonia e la regola che governano la forma del mondo e la figura della storia, e la sua opera scandisce, per molti versi, la misura identitaria della fotografia isolana con cui dovranno confrontarsi i fotografi della generazione immediatamente successiva.
“Nato a Bagheria, tra i giardini di limoni e il mare, un grosso paese che gravita su Palermo […] abitato dalla follia del Principe di Palagonia che vi fece costruire una villa, nella metà del Settecento, popolata da mostri in arenaria”, Ferdinando Scianna decide di diventare fotografo suscitando l’ironica contrarietà del padre: “Adesso vuole fare il fotografo. Come quello che risuscitava i morti e ammazzava i vivi. Quando mio padre era bambino c’era in paese un solo fotografo e lo chiamavano per fotografare i morti, perché ci fosse almeno un’immagine da mettere sulla tomba. I vecchi non si volevano fare fotografie da vivi, la fotografia era troppo strettamente legata all’idea della morte. Lui ritoccava gli occhi sul negativo e mostrava la foto orgoglioso: guardate, sembra vivo. Ma i suoi ritratti dei vivi sembravano immagini già pronte per la lapide del cimitero […]. La mia scuola di fotografia sono stati i libri, i giornali e Enzo Sellerio. Le sue fotografie mi sembrarono subito formidabili, e lo sono. Lo andavo a trovare ogni mese, più o meno, con un pacco di stampe sotto braccio […]. Lui sfogliava le mie foto e diceva qualche parola, un giudizio, una battuta, qualche abbozzo di considerazione generale […]. Ogni volta che gli rendevo visita facevo un salto di qualità, che altrimenti avrei forse messo degli anni a fare. Attraverso di lui sono subito entrato in contatto con la più grande tradizione fotografica europea e con una personalità di livello internazionale. Poi, un giorno, Sellerio mi disse che ormai lo sapevo benissimo da solo quali fotografie erano buone e quali cattive.” Scianna ricorda di essere andato via dalla casa di Sellerio un po’ confuso, ma quel complimento, che era anche un congedo, era il riconoscimento di una visione ormai matura. La festa religiosa in Sicilia è il primo tema che affronta il giovane Scianna, con lo sguardo critico e privo di qualsiasi illusione sul destino eterno dell’uomo; le sue immagini, forse per questo, sono in grado di rivelare la verità antropologica, grande e terribile, che allora era ancora possibile esperimentare nella rituale solennità della devozione popolare isolana.
Dopo aver visto casualmente queste fotografie da un comune amico, Leonardo Sciascia scrive un biglietto di congratulazioni a Scianna e, dopo averlo conosciuto di persona, promuove la pubblicazione delle immagini in un libro con una sua prefazione. Ferdinando Scianna trova così il coraggio di abbandonare la Sicilia e di partirsene per Milano, dove riesce in breve tempo a farsi assumere come fotografo dal settimanale “Europeo”. “Penso che sia stato un buon giornale d’immagini, uno dei migliori d’Europa in rapporto alla sua formula e ai suoi mezzi”, ricorda Scianna il quale, lavorando all’interno della redazione con tenace genialità, riesce a far equiparare giuridicamente lo statuto dei giornalisti a quello dei fotografi. Lo stesso Scianna viene infine mandato come redattore e corrispondente a Parigi: “A un certo punto, forse per indegnità, sono stato degradato a giornalista, mestiere più facile e perciò meglio retribuito”. Abitare nella capitale francese consente a Scianna di conoscere e frequentare Henri Cartier-Bresson, che nel 1982 lo consiglia di proporre la sua candidatura a membro della Magnum, dove viene subito accolto: “Sono così entrato a far parte di un gruppo che fin da quando, ragazzo, avevo cominciato a fare fotografie, sempre avevo guardato come un mito”. Scianna può tornare così a fotografare in maniera continua e definitiva, nella consapevolezza che l’apparenza del mondo diventa rappresentabile soltanto attraverso l’onestà obbiettiva del suo sguardo: “Io penso che la fotografia non sia lo specchio della realtà, è la realtà ad essere lo specchio del fotografo […]. Senza illusione di sorta, ormai, ma con l’intatta passione per il gioco estetico, ed etico, del tentare di dare forma al caos; sia pure la fragile, puntiforme, insensata forma di un istante. Viaggiare e pensare e fotografare pensando significa fare i conti con il dolore, la stupidità, la ferocia, la follia degli uomini. Il mondo pare volersi sfracellare, lurido e insanguinato, contro il muro di confine del secondo millennio”. Il mondo è entrato nel terzo millennio senza sfracellarsi, allo stesso modo della fotografia di Ferdinando Scianna, forse perché quella di Scianna non è la fotografia di un fotografo, ma la fotografia di un uomo a cui il mondo riguarda davvero.
Le immagini che hanno reso celebre nel mondo Letizia Battaglia sono quelle dei morti ammazzati nella guerra di mafia durante gli anni Settanta e Ottanta dello scorso secolo. Immagini di cronaca ai cadaveri abbandonati nelle strade, riversi nei sedili di auto dai finestrini infranti o inclinati nell’ultimo sonno sui divani e sulle poltrone di desolate scenografie palermitane.
Pubblicate sui quotidiani siciliani, italiani e internazionali, le fotografie di Letizia Battaglia hanno infiammato i cuori della società civile isolana e nazionale scossa da quella ondata di terrore e di orrore e hanno animato le coscienze dei politici e dei magistrati che in quegli anni cercarono di ristabilire una forma di giustizia e legalità nella città di Palermo.
Il passare del tempo non ha consumato il valore esistenziale di queste fotografie, ma sembra aver loro conferito una profondità inimmaginabile al tempo dello scatto che, abbandonata la dimensione effimera della cronaca, è diventata storia emblematica dell’universale tragedia del vivere.
L’essenzialità istintiva dell’inquadratura, la durezza estrema delle tonalità in bianco e nero non concedono allo sguardo alcun punto di vista ulteriore a quello della violenza omicida che ha abbattuto la vita di uomini e donne sulla superficie della terra, indelebilmente macchiata dall’oscura macchia del sangue. Nella visione di Letizia Battaglia emerge il mondo dei vinti senza riscatto, che fu già in scrittori come Giovanni Verga e Federico De Roberto, una visione tipica della tragedia moderna, quella che rifiuta il Teatro della Misericordia e non conosce l’ordine e la misura della tragedia antica la quale, attraverso l’epica bellezza della rappresentazione scenica, riesce a portare l’osservatore alla catarsi: liberare l’uomo attraverso la mimesi l’arte, alleggerendo la coscienza dalla passione mortale indotta nel cuore dal terrore e dall’orrore generati dal male.
5. Isola nuova.
Una cosa ricorda Gesualdo Bufalino: “Accanto a una Sicilia immobile o che sembra tale, un’altra, più o meno sommersa, si va clamorosamente muovendo e s’allontana ogni giorno di più dai modelli culturali dei padri”; e nell’isola, tra la fine del novecento e la prima decade del terzo millennio, una sorta di rigetto non detto e non dicibile della tradizione culturale ha prodotto un’epocale cambiamento del paesaggio e della modalità di vita, in un riuscito tentativo di assimilazione ai modelli offerti dalla globalizzazione. Nel crollo di ogni utopia sociale e nel sostanziale fallimento dell’autonomia politica regionale pare anche essersi dissolta ogni fiducia in un possibile cambiamento positivo della condizione umana. Tutti gli ismi dell’epoca moderna sembrano essersi fusi insieme, generando un nichilismo diffuso e opaco e nella visibile evidenza dell’inesorabile e ineludibile morte del corpo sembrano anche essersi dissolti ogni fede e ogni possibile pensiero, filosofico e razionale, riguardo all’invisibile perennità dell’anima e alla finale resurrezione della carne. La salvaguardia dell’ortodossia nella Chiesa si è attestata soltanto nell’angusto spazio della dimensione verbale della Parola, tralasciando ogni discorso sulla forma dell’architettura, sulla figura dell’immagine e sull’armonia della musica e il grande apparato delle feste religiose ereditate dal Barocco e dalla Riforma Cattolica sembra reggersi più in funzione del turismo di massa che come sincera adesione corale del popolo isolano.
“Afa. Immobilità di piante enormi. Un cane urla. La testa, barcollando, trattiene sull’orlo della memoria labili numeri di telefono e visi. Se c’è una tragedia vera, dove sipario è mantello, muore non l’eroe fiero, ma, cadendo in sfacelo, logorata la scena”, scrive in una poesia Josif Brodskij durante un’estate trascorsa a Cape Cod, meditando sulla condizione umana alla fine dell’epoca moderna. La Sicilia che i fotografi hanno amato, sempre ritornandovi come Ferdinando Scianna o rimanendovi fedeli attraverso le difficili peripezie del vivere come Nicola Scafidi, Enzo Sellerio, Letizia Battaglia, sembra essere defunta come scena viva del presente e sembra permanere oggi soltanto come una mummia della Cripta dei Cappuccini di Palermo o come l’immobile cane Bendicò disteso sul pavimento del nobile salone del Gattopardo: “Questo cane è diventato veramente troppo tarlato e polveroso. Portatelo via, buttatelo!” Si può leggere nell’ultima pagina del romanzo di Lampedusa: “Mentre la carcassa veniva trascinata via, gli occhi di vetro si fissarono con l’umile rimprovero delle cose che si scartano, che si vogliono annullare. Pochi minuti dopo quello che rimaneva di Bendicò venne gettato in un angolo del cortile, che l’immondezzaio visitava ogni giorno. Durante il volo giù dalla finestra la sua forma si ricompose un istante: si sarebbe potuto vedere danzare nell’aria un quadrupede dai lunghi baffi e l’anteriore destro alzato sembrava imprecare. Poi tutto trovò pace in un mucchietto di polvere livida”.
Così una visibile discontinuità esistenziale e culturale viene posta in essere dagli autori nati nel 1959 come Sandro Scalia o nel 1960 come Carmelo Bongiorno e Carmelo Nicosia. La loro opera si origina consapevolmente e criticamente su altri temi e con modalità visive diverse e non si muove più nell’ambito del giornalismo e dell’editoria, ma nel sistema dell’arte contemporanea.
Anche Sandro Scalia, per mettere a fuoco la propria visione, prende la via del nord, diplomandosi alla Scuola Umanitaria di Milano con Roberta Valtorta che stava diventando una delle figure di riferimento della nuova fotografia di paesaggio, promossa dalle mostre e dai volumi Luogo e identità nella fotografia europea contemporanea del 1983 e Viaggio in Italia del 1984. Tornato in Sicilia e stabilitosi a Palermo, Scalia ha maturato una visione personale capace di mantenere l’indice di realismo proprio della fotografia e, nella salvaguardia della forma e della figura nel visibile, riesce a mettere ancora in scena il dramma del contemporaneo isolano. Scrive Roberta Valtorta: “Sappiamo che il fotografo è un grande camminatore, è, a volte, il flaneur di cui parla Walter Benjamin: percorre i luoghi della città e insieme vive pezzi della sua vita, raccoglie frammenti e li fissa, avido o pensoso. Talvolta misura lo spazio, talvolta cerca di ricongiungere il tempo che percepisce fuori di sé e il tempo che scorre dentro di lui. Questo è, infine, l’agire del fotografo […] Scalia ha composto più città, luoghi diversi nei quali si incrociano figure di bambini, nuove urbanizzazioni, mercati, giardini, interni di chiese, cieli, lunapark, il porto, il mare, grandi condomini, graffiti, storici palazzi in decadenza, piazze, automobili. Colore e bianco e nero, […] non si tratta però solo di una differenza di soggetti né di scelte tecniche, ma di continui spostamenti della visione e dell’esperienza stessa del fotografo”. Il formato prediletto da Scalia è quello stretto e lungo dato dalla proporzione 1×3 e, nell’immagine policentrica ed eccentrica propria della cultura barocca, riesce così a rimettere in movimento lo sguardo dell’osservatore verso il senza fine che, nell’orizzonte del mondo visibile, continuamente cerca l’invisibile profondità del cuore.
Carmelo Bongiorno e Carmelo Nicosia s’incontrano a Catania mossi dalla passione per la fotografia e, insieme al più anziano Carmelo Mangione, all’inizio degli anni Ottanta costituiscono il gruppo Fase per cercare e trovare le modalità di una visione nuova e diversa capace di dare ragione della condizione contemporanea. In quattro anni di discussione e di ricerca comune raggiungono la consapevolezza che è ormai inutile e impossibile la messa a fuoco di un’immagine obbiettiva del mondo. La fotografia diventa quindi la traccia sensibile e istantanea di un sentimento e di un pensiero che hanno perso ogni fiducia nella consistenza reale del mondo visibile, rimanendo come unica certezza la passione dello sguardo trafitto dalla luce e accecato dal buio.
Come per Gesualdo Bufalino, anche per Bongiorno “l’isola tutta è una mischia di lutto e luce. Dove è più nero il lutto, ivi è più flagrante la luce, e fa sembrare incredibile, inaccettabile la morte” e L’isola intima è il titolo della prima opera significativa da lui realizzata. Nella greve tonalità dei grigi, nel tenebroso spessore dei neri che rendono ancora più lancinanti e struggenti le bianche luci del crepuscolo che svaniscono nel buio della sera che avanza, le immagini di Bongiorno si fondano su pochi elementi in inquadrature scabre ed essenziali tese al centro, o semplicemente sviluppate sulla diagonale o sul contrappunto: il ponte di un traghetto, un balcone a picco sul mare, il selciato di pietra sotto un arco, un polveroso sentiero verso le colline, la maschera mortuaria di Bellini, una mano tra le pagine di un libro, l’incendiarsi di alberi sotto un’eruzione notturna, l’illuminarsi di schermi televisivi in tetre stanze, il decollo di un aereo in un livido tramonto.
Nella cultura della fotografia contemporanea la fisicità del mondo viene ancora salvaguardata in alcuni autori dalla camera chiara della memoria attraverso il riflesso immoto e cristallino dell’obbiettivo sempre a fuoco. Bongiorno riflette invece il proprio itinerario nella terra d’origine dentro la camera oscura della rimembranza e, nella consapevolezza del melanconico trapassare di tutte le cose, sfuma ogni nitida concretezza delle forme per mettere a fuoco l’esperienza interiore e altrettanto obiettiva dei propri sentimenti. L’attraversamento dell’isola in queste immagini assume quindi la dimensione originaria dell’attraversamento del labirinto, di un percorso iniziatico che indica e rivela la dimensione nascosta ed ultima della realtà.
“Magro e schivo amavo allontanarmi da tutto, ed entrato in mare nuotavo fino a non sentire più le voci della spiaggia”, racconta Bongiorno, “[…] trattenendo il fiato mi immergevo lentamente sotto la superficie dell’acqua nuotando pian piano fino a restare quasi immobile: quindi aprivo gli occhi […] attraverso il filtro dell’acqua lievemente increspata, velocissimi bagliori di luce bianca attraversavano il mio corpo rendendo tutto insolito, misterioso, forse più vero”. Attraverso questa esperienza dell’infanzia Carmelo Bongiorno accede alla dimensione universale dello stare al mondo propria della mortalità dell’uomo: è la dimensione del mondo prima di venire al mondo, o la dimensione del mondo quando si sta uscendo dal mondo. Così, nelle sue immagini le forme e le figure del mondo appaiono sempre sulla soglia del nascere e del morire, tra l’alfa e l’omega della loro esistenza, corpi di luce circondati da un buio profondo senza fine e i luoghi, le persone, le cose non sono rappresentate nell’istante della loro pienezza, ma sono colte nell’attimo aurorale del loro farsi e in quello mortale del loro disfarsi. Immerso in un nero assoluto, da questo punto senza consistenza eppure reale, Bongiorno interroga la luce interna che sembra sostenere la vita di tutto ciò che sino ad oggi è apparso come un effimero bagliore davanti ai suoi occhi.
Malgrado la necessaria somiglianza con la visione di Carmelo Bongiorno, significativamente diverso è il senso dell’immagine di Carmelo Nicosia e i suggestivi titoli dati alle sue opere, Stelle erranti o L’ultimo sole, indicano che la sua ricerca si concentra sui simboli primigeni e originali del mondo, l’aria, l’acqua, la terra, il fuoco. “Le immagini rappresentano i momenti rituali del viaggio e della navigazione”, racconta di sé Carmelo Nicosia, “le tensioni dello sguardo e il ritmo delle attese, gli approdi e le aspettative del viaggiatore; il senso dell’altitudine nel vulcano Etna solcato dalle tracce degli escursionisti, camminanti alla ricerca di senso e di altitudine visiva”.
Nella ricerca artistica di Carmelo Nicosia l’elemento aria nella visione dall’aereo in volo prende la consistenza di materia fotografica: “Dopo una serie di esperienze vissute in prima persona, sperimentate dopo anni di narrazioni familiari in quanto figlio di un pilota, di analisi di archivi storici, di riflessioni sulla diversa prospettiva aerea, l’angolazione che lo sguardo assume dall’alto, visione altra e alta. Osservando il paesaggio contemporaneo dall’alto, alterando la visione prospettica a misura d’uomo, la natura e l’architettura assumono le sembianze di un circuito elettrico, un ordinato transistor, schema di moduli metallici che scintillano al sole, piccolo agglomerato costituito da moduli come elementi di un’architettura ordinata e consequenziale. Dall’alto tutto appare possibile, un flusso spazio-temporale parallelo, in linea con una diversa visione fatta di spostamenti repentini e di transiti in non luoghi che a furia di essere frequentati divengono gli unici possibili per la visione, per osservare il tempo presente”.
6. Epilogo.
L’avventura di chi, nell’Occidente del mondo, per caso o per destino, realizzi fotografie è sempre personale, unica, singolare e non confrontabile con quella di nessun altro, dall’umile artigiano quale ha sempre sostenuto di essere Gianni Berengo Gardin sino all’artista che ha sempre cercato di essere Mario Giacomelli. Così, questo breve saggio sull’identità della fotografia siciliana e dei suoi più importanti autori nel secondo dopoguerra si pone come il tentativo di mettere a fuoco la condizione e il problema dell’essere fotografi.
“Dicono gli atlanti che la Sicilia è un’isola e sarà vero, gli atlanti sono libri d’onore”, ricorda Gesualdo Bufalino: “si avrebbe però voglia di dubitarne, quando si pensa che al concetto d’isola corrisponde solitamente un grumo compatto di razza e costumi, mentre qui tutto è mischiato, cangiante, contraddittorio, come nel più composito dei continenti. Vero è che le Sicilie sono tante, non finirò di contarle […] tante Sicilie, perché?”
Bibliografia
Richard Avedon, (1993). An Autobiography. New York: Radom House Publishing Group.
Richard Avedon, (1994). Evidence. 1944- 1994. New York: Ediztion
Giorgio Agamben, (2004). Il giorno del Giudizio. Roma: Nottetempo.
Gesualdo Bufalino, (2001). Opere. Milano: Bompiani.
Xavier Bray, The Sacred Made Real, London 2009, Washington 2010.
Carla Bino, (2008). Dal trionfo al pianto. Milano: Vita e pensiero.
René Girard, (2001). Vedo Satana cadere come la folgore. Milano: Adelphi.
Nadia Fusini, (2010). Di vita si muore. Milano: Mondadori.
Wladimiro Settimelli, (1976). Giovanni Verga. Specchio e realtà. Roma: Editrice Magma.
Andrea Nemiz, (1982). Capuana Verga De Roberto Fotografi. Palermo: Edikronos.
Sebastiano Gesù. (2006). La terra trema. Un film di Luchino Visconti. Lipari-Comiso: Centro Studi Eoliano.
Ennery Taramelli, (1995). Viaggio nell’Italia del Neorealismo. Torino: Editrice Internazionale.
Nicola Scafidi, (1993). U Scaru. Palermo: Edizioni Dorica.
Nicola Scafidi, (2001). Fotografie. Milano: Motta Editore.
Enzo Sellerio, (1977). Inventario siciliano. Palermo: Sellerio.
Enzo Sellerio, (2004). Per volontà o per caso. Milano: Nottetempo.
Enzo Sellerio, Fermo immagine. Firenze 2007.
Ferdinando Scianna, (1987). Feste religiose in Sicilia. Palermo: L’immagine Editrice.
Ferdinando Scianna, (1977). I siciliani. Torino: Einaudi.
Ferdinando Scianna, (1989). Le forme del caos. Udine: Art&.
Letizia Battaglia, Franco Zecchin, (2006). Dovere di cronaca. Roma: Catalogo della mostra.
Letizia Battaglia, (1999). Passion Justice Freedom. New York: Aperture.